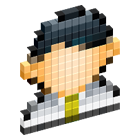lo scrivo a parole perchè l'ho svolto a matita su un foglio (tipo bozza) ed è un po' confuso.
ESERCIZIO 1.
a) bisogna calcolare z(t), cioè il segnale che va in ingresso all'ultimo blocco. Prima di tutto si moltiplica x(t) per 2 cos (2πf1t), viene un segnale che chiamo a(t) ed è uguale a una somma di due coseni con frequenze f3= 5 ed f4 = 3 [a questa somma di coseni ci arrivi con le formule di Werner cos(a)*cos(b) ]. Questo a(t) va in ingresso al blocco S1, di cui abbiamo la risp impulsiva. Antitrasformando, trovo la risp in frequenza e viene ù
H1(f) = rect (f / 2 W1) quindi noto che in pratica è un filtro passabasso ideale con frequenza di taglio W1.
Trasformo anche il segnale a(t) per vedere le sue componenti in frequenza e (essendo somma di due coseni) ha 4 termini impulsivi, due a freq, 5 e due a freq 3. Quindi per il filtro passano solo le due componenti a -3 kHz e +3 kHz, e ne esce quindi b(t) = cos( 2 π 3 t).
Questo b(t) va a sua volta moltiplicato con un altro coseno a freq f2 = 3 e ne esce c(t) che è somma di due coseni, che va poi in ingresso al blocco S2. Agendo come prima, vedo dalla risp in freq di S2 [H2(f) = 1 - rect(f / 2W2) ] che si comporta come un filtro passa alto ideale che blocca i segnali tra -3 e 3 kHz. Quindi in uscita dal blocco avremo solo la componente a 6kHz di C(f), per cui
z(t) = cos (2 π 6 t).
b) per y(t) basta elevare z(t) al quadrato e poi si usa la formula del cos^2.
c) sulla potenza mutua ho qualche dubbio. Per definizione la potenza mutua è < z(t) y(t)* >. Ma essendo un segnale reale, il coniugato di y(t)* = y(t) stesso. (questa prendila con le pinze, non ne sono sicurissimo).
Quindi ho fatto (come da definizione) il limite dell'integrale e mi trovo: al numeratore una somma di sue seni, al den 72 π z, con z che tende a infinito viene 0.
Un'alternativa poteva essere il calcolo delle due potenze singole e poi vedere se sono ortogonali (ma non ho saputo procedere su questa strada).
ESERCIZIO 2
a) la cosa importante è tenere presente che stiamo lavorando con un sistema LTI! Quindi se x(n) = 1, anche x(n-1) = 1 e x(n-2) = 1. Quindi ci troviamo 1 uguale a 1 + a * 1 + b * 1 -> a = -b;
sostituendo cos(pn) nell'espressione viene: cos(pn) + a cos[p(n-1)] + b cos[p(n-2)] = 0;
ora sappiamo che cos(pn) = -1 per n dispari e 1 per n pari. quindi basta ipotizzare di avere n pari o n dispari e troviamo in entrambi i casi il risultato a - b = 1. Mettendo insieme le due espressioni in un sistema, troviamo la soluzione a = 1/2 e b= - 1/2.
b) riscrivo l'espressione di x(n) adattandola alla relazione i-u che abbiamo, cioè la scrivo 3 volte, prima normale, poi traslata di -1 (e moltiplicata per 1/2) poi traslata di -2 (e moltiplicata per - 1/2).
Come prima, provo a vedere con un n pari cosa viene fuori e mi trovo tanti gradini e impulsi, traslati e sommati tra di loro.
Il trucco qui è che siamo a tempo discreto, quindi un gradino u(n) non è altro che una sommatoria di impulsi!
Quindi possiamo vedere la soluzione graficamente. Disegnamo prima u(n), cioè una serie di impulsi di altezza 1 che partono da 0 in poi.
Poi abbiamo un termine 2d(n), che è un impulso di altezza 2 nell'origine. Quindi nell'origine ci troviamo un impulso di altezza (2+1) = 3!
C'è 1/2 d(n-1), quindi sommiamo ad ogni impulso (a partire da 1 verso destra) un altro di 1/2...e cosi via!
ESERCIZIO 3
In questo tipo di esercizi, per trovare il valore k di una PDF si sfrutta la proprietà della normalizzazione. Si pone l'integrale della pdf = 1.
Il dominio della pdf è D = {(x,y) € R2 : 0<= y <= 1-x , 0 <= x <= 1}
quindi svolgo l'integrale doppio su D e trovo k = 24.
Per la pdf marginale ci basta integrare la pdf confiunta nella variabile che non ci interessa. Quindi faccio l'integrale prima in dy (con dominio normale rispetto a x) e poi in dx (dominio normale risp a y). Cosi troviamo le soluzioni.
La probabilità che P(X>Y) si calcola sempre con un integrale della pdf congiunta, ma bisogna modificare il dominio.
Scriviamo un dominio A che rispecchia l'area che ci interessa, cioè dove x>y , e lo intersechiamo col dominio di partenza e troviamo
A intersecato D = {(x,y)€ R2 : 0<= y <= 1/2; y< x <1-y }
e svolgendo l'integrale doppio troviamo P = 1/2.